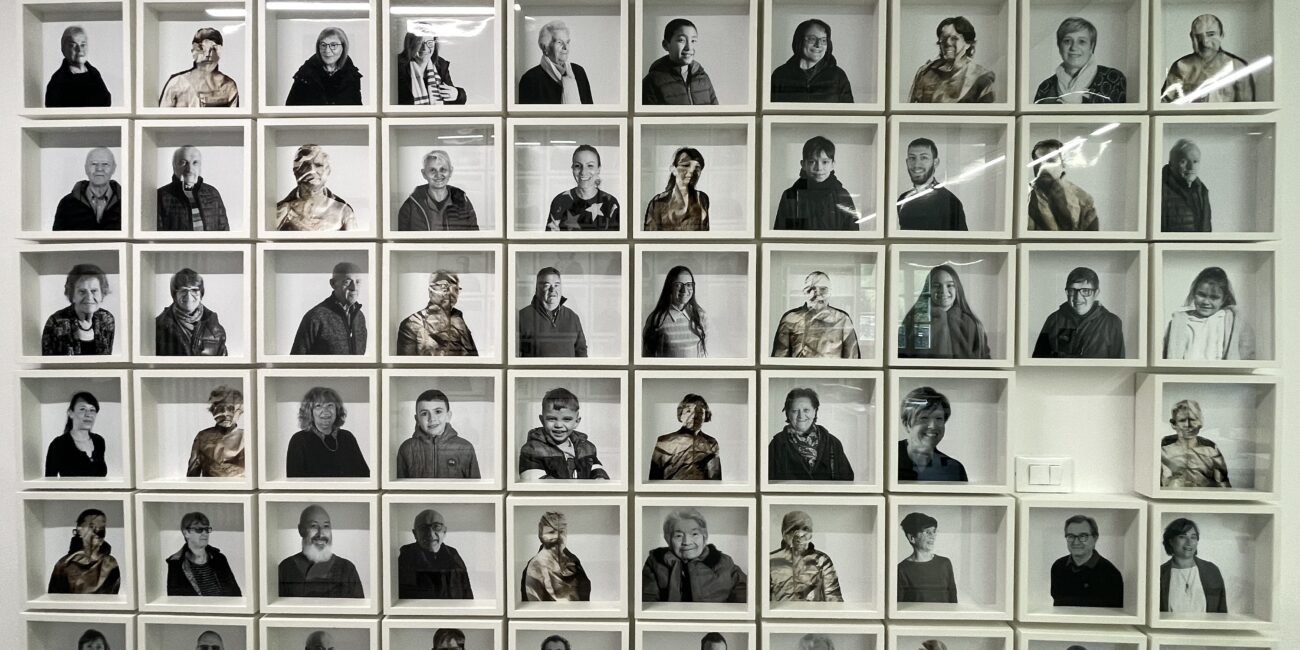Bruni Ritter è nato nel Canton Zugo a Cham (Svizzera) nel 1951. Si è trasferito a Canete in Valchiavenna (So) nel 1982, poi in Bregaglia (Svizzera) nel 1994, prima a Maloja e quindi a Borgonovo, dove vive tuttora, operando da pendolare a Chiavenna (So). All’inizio, un forte influsso sulla sua riflessione artistica viene dalla montagna. L’artista vive a stretto contatto con la montagna che incombe e incalza, e quest’ombra, una volta minacciosa, una volta misteriosa, s’inserisce nella sua opera. I suoi quadri non mostrano solo le montagne, ma anche la gente, l’atmosfera, ritratti e paesaggi. Ha allestito esposizioni in Italia, Austria, Svizzera e Germania. Collabora con la Galleria Jörg Stummer di Zurigo (Svizzera), il Centro Culturale Kunstraum Riss di Samedan (Svizzera), la Galleria art.ist di Castrop Rauxel (Germania) e la Galleria Bader di Lucerna (Svizzera). “Già agli esordi”, a parere di Beat Stutzer, “Bruno Ritter è stato definito ‘artista di frontiera» alludendo così alle sue tappe biografiche contrapposte, presso i confini di stato a Sciaffusa, dove negli anni ’70 operava e gestiva un atelier d’incisioni per litografie e acqueforti, e in Valchiavenna, dove si trasferì nel 1982. Ma si parlava anche di ‘arte di confine’, del pendolarismo dell’artista nel suo confronto approfondito con la tradizione pittorica dell’arte nordica, francese ed italiana. Per Bruno Ritter, inoltre, i confini tra arte figurativa, astratta e persino non-oggettiva non sono mai stati rilevanti, bensì così labili, che lui riesce consapevolmente, ma anche conscio del pericolo equilibristico presente tra questi poli apparenti, a muovervisi magistralmente.
Gli stati metamorfici tra corpi e paesaggi, ad esempio, gli antagonismi tra profondità e trivialità, tra palese chiarezza e metaforismo a doppio senso e talvolta anche tra un’estetica brillante e una stucchevole banalità interessano particolarmente a Bruno Ritter: una strategia artistica che gli consente di strappare alle sue immagini interiori che s’impongono nella sua mente qualcosa di enigmatico. Banali faccende quotidiane e osservazioni acute, come costellazioni gestuali ed effimere, con Ritter variano per lo più tra descrizione narrativa e profondissimo metaforismo. In questo ambito la pittura di Ritter è addirittura corredata da qualche insidia. Né il fine ductus del pennello, il quale sa strutturare a meraviglia oggetti e superfici, né le insistenze vibranti e pulsanti della pittura, nemmeno la scintillante, delicata e a volte sorprendente cromatica e nemmeno la complessa spazialità possono far illudere che dietro allo splendore della pittura non si nasconda nient’altro. La perfezione di Bruno Ritter che a tratti appare addirittura magistrale può alludere a ciò: che egli non solo conosce a fondo la storia dell’arte, ma anche che lui si confronta costantemente sia formalmente che iconograficamente con la pittura del passato – e facendo ciò s’impone dei parametri molto rigidi per quanto riguarda il suo operato artistico”.