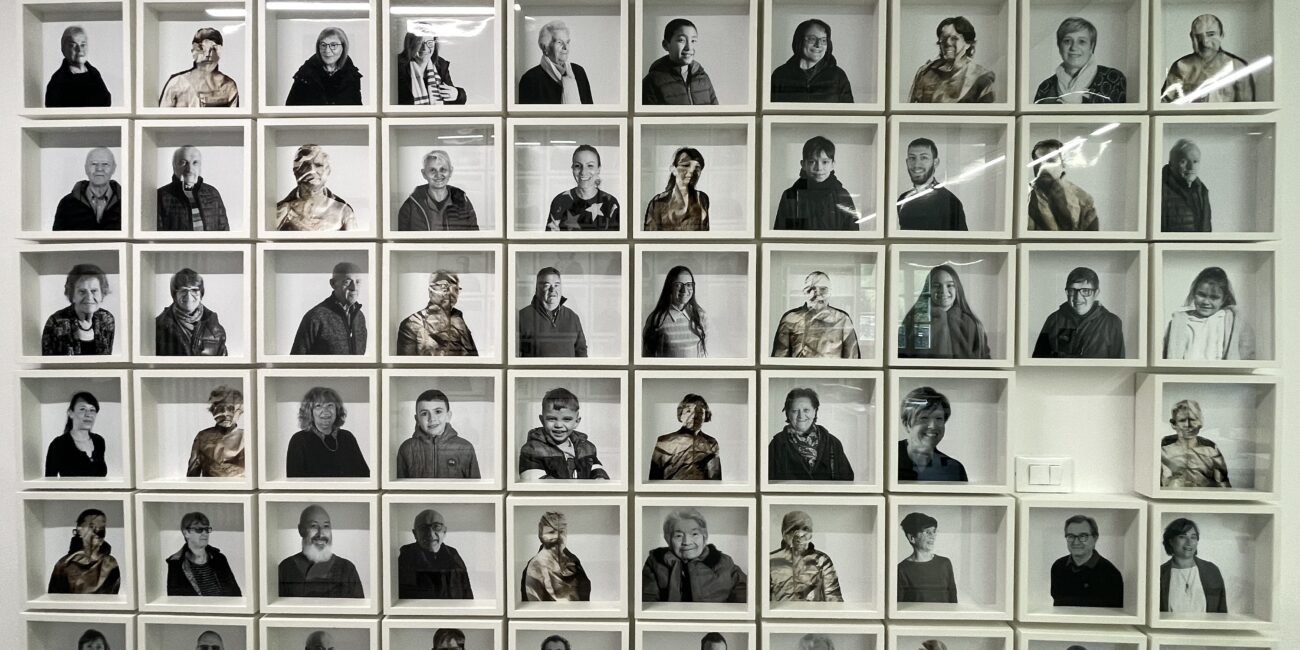Francesco Capello è nato nel 1944 a Chivasso (To). Dopo la Maturità Artistica, si è diplomato all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. È stato docente di Discipline Pittoriche al Primo Liceo Artistico Statale di Torino fino al 1994. Dopo una serie di prestigiose mostre negli Stati Uniti ed in Europa, nel 1999 gli viene dedicata una personale nella sala delle Colonne al Castello del Valentino di Torino. Nel 2002, ha esposto a Monaco, nelle prestigiose sale del Metropole Palace in una mostra organizzata dal Rotary Club e sotto l’alto patronato del Principe Alberto di Monaco. Nel 2004, la città di Chivasso gli dedica una mostra antologica nello spazio pubblico di “Palazzo Einaudi” presentata e presenziata dal critico d’arte Vittorio Sgarbi. Negli anni successivi ha lavorato con parecchie gallerie, in particolar modo negli Stati Uniti, collaborando tra le altre con “Gallery Biba” di Palm Beach e “Bernarducci Meisel Gallery” di New York. Sue opere sono in esposizione permanente al Museu Europeu d’Art Modern MEAM di Barcellona, al M.A.C.I.S.T. di Biella, alla Pinacoteca Civica di Chivasso, alla Biblioteca Civica “A. Arduino” Moncalieri, alla GAM Torino. Nel 2017, ha presentato la mostra L’arte e il mito al Museo Ferrari di Maranello e in seguito in occasione della Notte Rossa di Maranello 2017/2018 l’esposizione è stata inserita come Official Event. Nell’ultimo periodo è presente in importanti mostre collettive pubbliche e private in Italia e all’estero.
“La ricerca di Capello”, ha commentato Irene Cabiati nel suo articolo intitolato L’arte approda al Museo Ferrari, comparso su “La Stampa” del 24 febbraio 2017, “che da anni propone con successo le sue opere iperrealiste in Europa e negli Stati Uniti, si concentra sullo scorrere della quotidianità. Come un passante attento, l’artista di Chivasso (Torino) si limita ad osservare dando voce ai silenzi delle persone, degli oggetti e degli spazi con la perizia del Maestro che non usa stratagemmi tecnici o filosofici per testimoniare la propria bravura. Lo sguardo delle sue donne scavalca l’orizzonte per sciogliersi nella nostalgia, nell’inquietudine, talvolta nello smarrimento del dolore. Gli oggetti, piuttosto inquietanti per la raffinata e minuziosa somiglianza al reale, diventano protagonisti viventi nella loro essenzialità: biciclette, le auto e le moto d’antan, talvolta ritratte sotto la pioggia, infondono un profondo senso di solitudine che non è angosciante, anzi, può diventare uno stato di grazia in cui si può assaporare la quieta consapevolezza dell’esistenza. Le ambientazioni, nei porti, nei bar o nelle stazioni di servizio o nei vibranti paesaggi urbani – che evocano facilmente le situazioni care a Edward Hopper, l’esponente più noto del realismo contemporaneo – oppongono all’apparente vuoto esistenziale, la dinamica del silenzio che parla a voce alta”.